“Ernesto il disingannato” (romanzo del 1874) a cura di Gianandrea de Antonellis (VI)
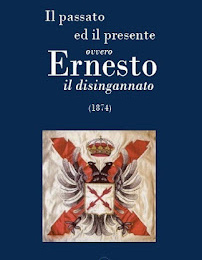
Capitolo II. Un poco di Storia
Prima di proseguire la narrazione che abbiamo incominciata, è necessario mettere sotto gli occhi del lettore un poco di storia; non però particolareggiata, né minutamente narrata, ma a volo di uccello ed in semplice modo di far comprendere un poco meglio i fatti che stiamo per raccontare
Fin dal 1848 i popoli della nostra Penisola erano tutti in fermenti per quella libertà predicata e sperata dagli arruffapopoli, cioè quella libertà che oggi abbiam veduto che cosa è.
Però in mezzo a questi nemici della patria eranvi i mille[1], i quali cercavano di fomentare la scintilla, facendola diventar fiamma incendiatrice per servire ai loro interessi, non per quelli dei ventidue milioni di uomini che la componevano, onde goder della cuccagna che certamente avrebbe prodotto.
Alla testa di questi tali, amanti della patria a loro vantaggio, vi erano tutti gli emigrati delle diverse parti di quella terra, che compromessi nell’anno 1848 nei diversi paesi, ritornati dopo quell’epoca nell’ordine e sotto i governi legittimi, erano fuggiti in Piemonte ed attendevano colà la forza degli avvenimenti, per poter ritornare nei patrî focolari e diventare fra i primi i primi, dopo di essere stati gli ultimi, e molti fra di loro gli ultimi fra gli ultimi, non avendo figurato che come comparse nel dramma rivoluzionario di quei tempi ed anelando d’impinguarsi, guadagnando centomila se avevano appena appena perduto cinquanta; s’univano agli emigrati coloro che sempre in quell’epoca memoranda – e quasi tutti questi erano figliuoli del nostro Regno delle Due Sicilie – erano stati meno destri e felici nella fuga ed erano stati arrestati e giudicati dai tribunali, e per diverse fellonie scontavano la loro pena nei diversi ergastoli e luoghi di relegazione, i quali, tutti uomini d’ingegno eminente e di grande ambizione, speravano mercé un cambiamento di riavere la libertà, agognando al potere per prendersi – dicevano essi – la rivincita delle sofferte pene, impinguandosi e, da colpevoli che erano stati, facendosi battezzare coi pomposi titoli di Martiri, Eroi, Apostoli di libertà.
Tutti costoro, mantenuti tra di loro in continue relazioni, quantunque in luoghi situati molto distanti gli uni dagli altri, non attendevano ad altro, con costanza degna di miglior causa, che a star fermi nei loro pensamenti ed in quella di trovare i modi di poter riuscire nel loro intento. Mille Comitati si erano formati sia nei Paesi distanti dall’Italia, sia nei vicini e per fino nella nostra Napoli, nonché nei medesimi carceri ed ergastoli per dirigere la bisogna; mille progetti si stabilivano, i quali aiutati dall’oro dei contribuenti, erano trasmessi dall’una parte all’altra per mezzo di messi segreti, spioni e traditori di ogni specie, genia che in tutti i tempi si trova sempre disseminata in tutte le classi della società. Questi Comitati, questi progetti erano coadiuvati dall’ambizione di chi aspirava a salir sublime, cingendosi di una corona che, ambita da tempo immemorabile, non era riuscito a niun potentato di adagiar sulla fronte.
Perciò Napoli, Roma, Milano, Torino, Firenze, Venezia erano le sedi principali dei Comitati di quella rivoluzione macchinata sotto la cenere e poi tutte le altre città davano il loro contingente di adepti, partigiani e cospiratori, i quali, quantunque camminassero nell’ombra e con la lentezza della lumaca, pure pianamente progredivano per arrivare a quell’opera di dissoluzione, di disordine, di immoralità, che a poco a poco doveva nella nostra bella penisola tutto travolgere, tutto distruggere, tutto annientare l’ordine preesistente e mettere in su la superbia, la ignoranza, la rapina e quanto di più turpe e terribile possa immaginarsi dagli uomini.
Napoleone iii, salito piano piano al potere mercé i mille sotterfugi ed infamie commesse in Francia e rivestitosi del pomposo titolo d’Imperatore, sorto dalla duplice caduta di una Repubblica effimera e di una usurpazione del legittimo trono di San Luigi, si era reso formidabile in Europa, se non con la forza delle armi, come un tempo suo zio[2], con quelli di una astuta e fina politica che avendo gettato le sue reti in tutti gli Stati, lo rendeva il padrone si può dire di tutti i gabinetti e di tutte le corti di Europa, diventando per così dire l’ausiliario di tutti i deboli contro i più forti, per far valere il principio di supremazia francese, principio che fino a quando credette potersi giovare pei suoi particolari interessi ed alle ambiziose sue mire fu da lui spalleggiato, facendolo trionfare a traverso di tutti gli ostacoli, mentre che poi arrivato al punto nel quale non gli poteva essere più di utilità, lo tradì e lo gettò nel fango, facendo perdere alla Francia in un momento, mercé una guerra mal calcolata e traditrice, tutto il prestigio di che fin’allora si era fatta superba, prostrandolo innanzi ad un’altra, grande sì, ma fino a quel punto secondaria nazione in faccia alla Francese.
Già la guerra di Crimea aveva mostrato che non bastava essere possente e grande come la Russia per poter resistere alla forza ed alla bravura francese, e siccome fin d’allora si era stabilito nei suoi piani formarsi un’amica, un’alleata, anzi starei per dire una serva nella vicina Italia, così questa si era fatta comparire anche come alleata in cotal guerra ed il piccolo Piemonte aveva anche dato il suo contingente, quantunque non avesse preso parte attiva quasi in veruna azione e mentre si dettavano patti avvilenti nelle smantellate mura di Sebastopoli allo Czar, si pensava d’ingrandire la piccola alleata, che da sua parte, non perché veramente l’Italia desiderasse ciò che dovette per forza subire, ma perché un Paese, ambizioso per fatti passati, voleva con quanto meno di pericolo si fosse potuto correre, innalzarsi al di sopra degli altri della Penisola e riscattare lo scacco subito nel Quarantotto non per mal calcolata ambizione e forse per opera pure di tradimenti e defezioni, ma voluto dalla onnipotenza di Dio, che tutte sperde le cospirazioni della superbia e della vanagloria.
Una parentela fra la famiglia Napoleonica e la dinastia Sabauda[3], aveva legati insieme i due interessi.
Il Conte di Cavour, uomo ambizioso a sua volta, immischiatosi mercé l’alleanza di Crimea[4] nei Consigli di Europa, aveva incominciato a far sentire la sua voce e predicava gl’interessi della sua patria – o per meglio dire del suo Re. Egli volgeva gli occhi da per tutto e, ovunque poteva vedere una via che lo conducesse al suo scopo, non tardava a mettervi il piede e, senza esitare, la percorreva arditamente e senza farsi arrestare da verun ostacolo.
In Italia fino all’epoca indicata il fermento era immenso, quantunque nascosto nel più segreto dei cuori, ma il Conte di Cavour lo fomentava proteggendolo quasi apertamente e preparava con arte sopraffina da per ogni dove le fiammelle che dovevan poi produrre l’incendio spaventevole che, scoppiato in Sicilia, divampò in un attimo ed al quale si diede il nome di rivoluzione dei popoli, ma che non fu che l’esito di un lungo e tenace concerto di un dramma macchinato a tavolino da uomini astuti, sviluppato con l’aiuto potentissimo dell’oro, retto ai fianchi dall’arte e dall’infamia.
Di tutti gli Stati italiani il più che dava da pensare ai sovvertitori era il Regno delle Due Sicilie: il più grande ed il più ricco ed agguerrito, governato da una famiglia gloriosa, celebre nella Storia e colma a ribocco di grandi antecedenti; non era perciò boccone da inghiottirsi con molta facilità; per cui era d’uopo camminare a passo di lupo e trattarsi le cose per l’adesione di esso alla grande causa, bisognandovi[5] mezzi eccezionali, perciò l’opera della propaganda più cautamente progrediva ed il denaro corruttore era seminato senza risparmio ed a larghissima mano. Magistrati, amministratori, artisti, militari di alto rango erano presi di mira e sedotti, mercé l’oro e le grandi promesse di future grandezze e, portando qualcuno poco più su nelle sfere sociali secondarie, si seducevano ed affiliavano [membri] di tutte le classi e fin quelle dei più bassi ordini, come si era fatto nelle altre città, per poter tenere nelle mani all’occasioni interi popoli senza trovar mai ostacolo alcuno.
Ciò premesso, siamo al punto di ritornare al nostro racconto, essendo l’anno che correva, il 1858, in cui di già si almanaccava o si preparava con pazienza il terreno, mentre da un’altra parte si maturava il progetto di guerra che doveva, come nell’anno antecedente era stata abbattuta la potenza russa, abbattere quella austriaca, guerra in cui gl’Italiani, coadiuvati sempre dai Francesi, vinsero e assisterono alla vittoria contro l’Austria e si ebbero in ricompensa la Lombardia dopo la pace di Villafranca, dalla quale unione col Piemonte cominciò a sorgere il tanto famoso e strombazzato dai rivoluzionari Regno d’Italia.
Capitolo III. La riunione
Appena sorse il giorno, Ernesto balzò dal suo misero giaciglio, abbracciò e baciò la sofferente madre ed uscendo di casa corse difilato da un venditore di abiti manifatturati, da un cappellaio, da un calzolaio e fornitosi di quanto poteva abbisognargli e vestitosi il più che poteva decentemente – del che la madre, che lo vedeva così male in arnese, si rallegrò tutta, cominciò dal correre nella vicina chiesa di San Lorenzo a ringraziare Iddio della fortuna mandatagli – e preparandosi per l’appuntamento delle ventitré ore al Caffè di Testa d’Oro.
La madre di Ernesto, buona e pia donna in tutta l’estensione della parola, non appena rimasta sola, si affrettò per mezzo di una fanciulletta che si prestava a servire le persone di quel cortile mercé una piccola monetuccia e fece chiamare a sé la giovinetta Emilia, che abitava anche in quel recinto, ma in un altro sito. Costei, non appena intese l’appello fatto dalla signora Martina, credendo che dessa[1] di qualche cosa abbisognasse, senza metter tempo in mezzo, postasi in tasca taluni piccoli risparmi, corse da colei che l’amava come figlia e che essa qual madre estimava, essendo la madre di quello che le faceva palpitare il cuore.
– Cosa bramate, madre mia? – domandò nell’entrare dall’uscio – Non appena ho inteso la vostra chiamata sono volata ed eccomi qui, pronta ad ogni vostro cenno, ad ogni vostro desiderio.
– Guardami figlia mia, – rispose la signora Martina – guardami e dalla mia cera più aperta ed allegra giudica che questa giornata è per me molto più lieta di mille altre e specialmente di quella di ieri. Ricordati l’ansia ed il dolore che mi tormentavano ieri per la protratta lontananza di mio figlio Ernesto; ansia e dolore che anche tu dividevi con me.
– Ma come non farlo, se voi sapete quali sono i sentimenti che per esso io nutro. – disse arrossendo ed abbassando gli occhi la buona Emilia.
– Lo so, rallegrati. Egli nella giornata di ieri soffrì molto, ma vide però il principio della fine delle sue disgrazie.
E ciò dicendo, seguitò a snocciolare tutto quello che era accaduto ad Ernesto nel giorno antecedente. La povera giovinetta fremette di orrore e di spavento e si spiegò qual era la ragione che, verso l’ora in cui Ernesto correva a precipitarsi dal Ponte della Sanità, essa si aveva inteso uno stringimento al cuore, che le aveva quasi tolto il respiro e che le aveva prodotto immensa pena ed affanno.
Poco dopo rientrò Ernesto, carico degli oggetti comprati, e vista colà la sua innamorata, corse a darle un casto bacio sulla fronte ed a giurarle, presente la madre, che se tutto quello che egli sperava si fosse avverato secondo le premesse fattegli, egli incontanente[2] l’avrebbe fatta sua sposa, la delizia della sua triste vita.
La giornata passò per quella famigliola allegramente, per quanto l’antecedente era stata colma di tristezza. I tre individui – cioè Ernesto, la madre ed Emilia – non vollero dividersi un istante e seduti ad un modesto desinare, passarono le ore fino a quella in cui il giovinotto recar si doveva al Caffè di Testa d’Oro, fra le gioie del presente e le speranze dell’avvenire.
Un’ora prima delle ventitré designate da don Antonio, Ernesto uscito di casa s’incamminò per la via dei Tribunali, uscì da quella a Toledo e piano piano arrivò al luogo del convegno circa un quarto d’ora prima delle ventitré. don Antonio non era arrivato ancora, di tal che egli, sedutosi innanzi ad un banchetto, bevve un poco di caffè e quindi attese l’arrivo del suo benefattore.
Poco di poi, don Antonio giunse anch’egli e visto appena Ernesto, corse a stringergli la mano e:
– Bravo, bravo, – gli gridò – bravissimo: avete fatto molto buon uso dei miei consigli, avete con questo fornita la vostra toletta. Questi abiti vi si attagliano magnificamente e posso ben dire esser voi nato in uno stato molto diverso da quello in cui di presente vi trovate, perché l’esservi abbigliato come siete indica gusto e gentilezza. Ora però è tempo di venire con me.
– Sono ai vostri ordini, signore.
Uscirono dal caffè e don Antonio, fatto accostare un piccolo carrozzino da nolo, vi salì col suo compagno, dicendo al cocchiere:
– Alla Villa Reale.
Arrivati nel ridente giardino pubblico, scesi dal cocchio, don Antonio prese come la sera antecedente l’amico sotto il braccio e passeggiando con lui nei viali più appartati della Villa, cominciò a tenergli questo linguaggio[3]:
– Amico mio, il pericolo è cessato, tu hai visto che la Provvidenza celeste non [ci] abbandona giammai, che il disperarsi è una vera sciocchezza e che fino a quando vi è in noi un alito di vita la speranza non deve giammai abbandonarci. Tu mi domanderai: a che questo esordio? Esso è destinato a farti comprendere che i tuoi guai di ieri, se tu hai giudizio e buona volontà, potranno in tutto e per tutto finire, e che una brillante fortuna invece ti è riserbata.
– Una brillante fortuna!…
– Da renderti, forse, l’invidia di quanti ti conoscono.
– Mio Dio, voi mi sorprendete in modo che io resto esterrefatto.
– Hai tu buona volontà?
– Quanta più ne volete.
– Attitudine al lavoro?
– Immensa.
– Sei di tempra forte da non temere i pericoli a cui, forse, il tuo novello stato potrà esporti?
– Siano quali esser si vogliano, purché sia pel bene della mia famiglia, li sfiderò ardito e senza tremare un istante.
– Giuri di mantenere il silenzio su quanto vedrai e ti sarà comunicato?
– Sulla mia fede di uomo onesto.
– Benissimo. La tua fortuna è fatta.
– Ma…?
– Saprai tutto tra breve.
Ernesto cominciò a comprendere trattarsi di qualche cosa di grave e siccome di quei tempi sia per gli avvenimenti che erano succeduti, sia per le circostanze in cui egli si trovava, era balenato anche al suo sguardo la folle speranza di un cambiamento di cose da cui poter ricavare una qualunque situazione ed uscire dell’ignavia e dalla esosa posizione di miseria e di squallore in cui si ritrovava, ed ora sentendo le parole di don Antonio, esaltato, ‹per poco› diceva fra sé e sé: «Forse si tratterà di qualche cospirazione, di qualche complotto politico atto ad aggiustare le faccende in questa nostra povera patria e dare così a chi ne manca un pane onesto e stabile. Ebbene, se ciò fosse, io volentieri accetterei; con tutta l’anima mi getterei nel numero di coloro che alla rigenerazione dell’Italia aspirano, al bene dei popoli oppressi, alla futura gloria di questa terra, di questa forte, ma avvilita nazione».
Le tenebre erano discese sulla città. don Antonio ed Ernesto erano giunti al di là di Mergellina, calarono fino alla riva del mare e, postisi in una barchetta, furono da un marinaio, già conscio del luogo dove doveva condurli, guidati quasi fino alla cosiddetta punta di Posillipo e colà, preso di nuovo terra, s’inoltrarono in una masseria e camminando per qualche tempo in mezzo alla terra coltivata, sparirono indi a poco in un antro che, principiando molto strettamente, si allargava quanto più si scendeva sotto terra e quindi, cangiandosi in una galleria sotterranea, dava l’idea quasi di una catacomba, si può dire molto al di sotto del livello del mare.
Verso la metà di quella vasta grotta si vedeva una piccola porta, custodita da due uomini armati, i quali all’appressarsi dei due nuovi venuti si posero sull’avviso e domandarono la parola d’ordine e, avutala, schiusero il piccolo uscio e lasciarono penetrare i due, che dalla prima passarono in un’altra sala, forse più vasta di quella, fornita di una lunga tavola, di diverse seggiole, lampade, libri, opuscoli, giornali e molta carta con l’occorrente da scrivere.
Rimase meravigliato Ernesto di trovare in quel luogo tutto ciò che abbiamo descritto: ma più meravigliato ancora, quando guardando d’intorno vide riunite colà diverse persone, dalla cera più aristocratica alla più lazzaresca; dall’età la più avanzata fino alla più florida ed imberbe; e, finalmente, dal non vedere in quella riunione nemmeno la mancanza del bel sesso, rappresentato dall’ostessa della Pignasecca e da una graziosissima giovinetta, vestita magnificamente, la quale seduta in mezzo a due zelanti zerbini, non perdeva né faceva perdere ad essi il tempo, lusingandoli[4] magnificamente e con tutta la malizia e le moine che si addicevano non ad una cospiratrice, ma ad una Frine[5].
Entrati i due nuovi arrivati e scambiato il medesimo motto d’ordine con colui che funzionava da preside di quella riunione, presero posto: don Antonio molto presso la tavola del presidente ed Ernesto in un luogo più appartato, aspettando l’esito di quel conciliabolo che andava formandosi.
Scorse dell’altro tempo nel quale tutti, chi scriveva, chi parlava col suo vicino a bassa voce, chi leggeva giornali ed il gruppo formato dalla bella donnina e dai due giovanotti non perdevano inutilmente il tempo, ed arrivati altri pochi individui, i due che erano a guardia dell’uscio d’ingresso, entrati anch’essi nella seconda galleria e sbarrata la porta, si aprì la seduta con un piccolo discorso fatto dal presidente, nel quale si conteneva in sostanza l’elogio di tutti i presenti componenti l’assemblea, dicendo, cioè, che essi tutti adempivano l’obbligo loro con tutta la possibile scrupolosità ed esattezza, e che ognuno era degno di elogio e di considerazione, ed annunziando in fine che gli affari andavano bene in generale; prese talune lettere in comprova di quanto accennava, scritte al Comitato Napolitano dai diversi Comitati di altre città, e specialmente da quello di Torino, che era quello dirigente in sostanza di tutte le primarie fila della cospirazione, e dopo uno scambio di notizie e di lettere, si venne al rendiconto particolare, fatto da tutti, di quello che particolarmente ognuno aveva operato per l’oggetto della riunione.
Ernesto, che si aveva di già formato in mente un certo criterio di ciò che poteva esser mai quella riunione, ebbe a persuadersi di non essersi ingannato e, siccome giovine inesperto ed ingenuo, ed uno di quelli cui veramente batteva il cuore per la creduta buona causa e ripieno, quantunque in misero stato, di forte amor di patria, si intese tutto consolare dal trovarsi anch’egli presente e facente parte di un’assemblea destinata a far risorgere l’Italia dalla sua pretesa schiavitù.
Il primo a render conto di ciò che si faceva in pro della libertà ‹si› fu un vecchio dalla chioma bianca, Siciliano, che parlava con accento caldo e spedito di tutto quello che era succeduto nell’Isola e di tutto quello che vi si preparava per una riscossa simile a quella del Quarantotto; ma però facendo rifulgere le cose in modo e magnificandole di tal maniera, che si poteva dai suoi detti benissimo arguire che l’esito di quel tempo darebbe risultati molto più fruttiferi e sicuri di quelli dell’epoca trascorsa, e ciò mercé la buona volontà dei Siciliani, la troppa oppressione a cui si facevano credere soggetti e soprattutto l’aiuto di [una] mano potente, che aiutava di nascosto la loro opera santa e mercé consigli, intrighi e denaro, preparava il terreno in maniera da far sì che gli affari non potessero avere che buoni ed eccellenti frutti, facendo in conclusione perdere e per sempre la Sicilia alla dinastia dei Borboni di Napoli.
Sorsero diversi altri dei componenti di quel Comitato, ed esposero dal più al meno il loro operato, e finalmente venne la volta della famosa ostessa, la così detta San Giovannara, che pur essa diede conto di quanto dal tempo dell’ultima riunione aveva fatto, assoldando parecchie braccia e preparando i popolani a tutto ciò che sarebbe stato necessario di farsi a tempo e luogo.
L’ultima che parlò fu la signorina gentile ed elegante, che tutta altera e burbanzosa addimostrò esser lei una delle principali e necessarie agenti di quella riunione e del Comitato napolitano, e di far essa solo tanto di bene quanto tutti gli altri componenti riuniti insieme non sapevano e non potevano fare. Disse che mercé i suoi vezzi ed i suoi alti talenti, nonché le aderenze che il suo stato e le conoscenze che aveva nell’alta Aristocrazia l’avevano procurato, aveva essa sola aggiogati al carro rivoluzionario tanti e tali uomini, che non se ne potevano sperare di più, e provando con documenti ineluttabili che oramai la maggior parte degli uomini di governo erano sedotti, presentò una lista di nomi dei quali non solo Ernesto, ma anche qualchedun altro dei cospiratori rimasero del tutto meravigliati.
Fatto tutto ciò che si è narrato, Ernesto fu presentato da don Antonio e raccomandato come uno dei più adatti alla bisogna di far da referendario ed intermedio nelle diverse classi della società che era necessario di tener d’occhio; fu stabilito che egli sarebbe stato adibito a far da finto commesso viaggiatore, per poter sotto tale qualità girare da per ogni dove, recando lettere, ambasciate, dispacci e tutto quello che era necessario per la più vasta estensione della cospirazione, e fu stabilito di presentarlo ad uno dei più ricchi negozianti della città, che avrebbe finto di farlo agire per suo conto; gli si assegnarono sessanta scudi il mese all’infuori di tutte le spese necessarie nei viaggi e nelle scorrerie da farsi per conto della società.
Ernesto rimase meravigliato ma, assicurato da tutti che egli avrebbe potuto essere più che utile alla causa della libertà, si rallegrò in se stesso e giubilò, persuaso che da allora in poi, diventando in primo luogo un Eroe, avrebbe aggiustati i fatti suoi in modo da poter dar da vivere alla sua buona madre e sposare la sua adorata Emilia; ricevette le congratulazioni di tutti i componenti l’assemblea e specialmente quelle della signorina, che adocchiatolo con somma conoscenza di causa e vistolo così avvenente e grazioso, sentissi destare per lui un affetto non certo della stessa natura di quello che la guidava in quel luogo, né tanto casto da poter camminare di pari passo all’amor di patria.
La notte era inoltrata per altro di poco, e dopo finita tutta la referenda[6] e fornito di tutto quello che era necessario farsi in quella notte per l’oggetto della riunione, il presidente dando un segnale fece sì che dalla parte interna della grotta si aprì una terza porta e tutti gli assembrati cambiando indole[7] si unirono allegramente e, passati in altra vasta sala fornita di tutto il confortevole, entrarono ad assidersi ad una lauta mensa, guarnita di quanto di più prelibato e sopraffino poteva rinvenirsi in fatto di cibarie squisite e vini deliziosi, ed onorata da altre sei belle damigelle del medesimo stampo della prima comparsa ad Ernesto, le quali, assise anch’esse a tavola, ebbero campo unite alla loro Capitana di poter benissimo fare gli onori del banchetto che più che a banchetto, paragonar si poteva ad orgia sfrenata, là dove a nome della unità, della libertà e della felicità futura d’Italia, si commetteva ogni specie di eccesso da quei novelli Catoni o Cincinnati e da quelle Eroine da postriboli, destinate ad essere le madri dei novelli Gracchi dell’epoca moderna, le succedanee della francese Dea Ragione.
Il tutto finì oltre mezzanotte ed Ernesto, entusiasmato per la sua novella fortuna e carica affidatagli, ricevuto prima di partire da quella riunione un dolce invito della Frine che lo aveva ben bene considerato, unitosi di nuovo con don Antonio, per la via di terra s’incamminarono e sbucati per mezzo di un’altra uscita sotterranea sulla via Maestra, si misero indi a pochi passi in una carrozza che li attendeva e furono condotti, con tutta sollecitudine nell’interno della città, d’onde separatisi e datosi un appuntamento pel domani, giorno in cui Ernesto doveva essere presentato al negoziante ed istallato nel suo nuovo ufficio di commesso cospiratore, ognuno prese la sua via, senza accadergli alcuna cosa di sinistro.
[1] Ella.
[2] Immediatamente.
[3] Discorso.
[4] Nel testo: «vezzeggiandosi».
[5] Famosa cortigiana greca, vissuta nel iv secolo a. C.
[6] Relazione.
[7] Nel testo: «carattere».
[1] Eranvi i mille:vi era una minoranza (rispetto al numero complessivo degli altri, i 22 milioni).
[2] Napoleone Bonaparte.
[3] Si riferisce al matrimonio celebrato il 30 gennaio 1859 tra il figlio di Girolamo Bonaparte – ex re di Vestfalia in quanto fratello minore di Napoleone Bonaparte – Napoleone Giuseppe Carlo Bonaparte detto Plon Plon (1822-1891) e Maria Clotilde di Savoia (1843-1911), figlia del re di Sardegna (e poi d’Italia) Vittorio Emanuele ii.
[4] Il Piemonte partecipò alla guerra di Crimea (1853-1856) e quindi fu ammesso al Congresso di Parigi (25 febbraio – 16 aprile 1856), in cui Cavour ottenne che per la prima volta in una sede internazionale si ponesse la “questione italiana”.
[5] Essendo necessari.
Il passato e il presente ovvero Ernesto il disincantato, romanzo anonimo
Prima edizione: Stabilimento Tipografico Partenopeo, Napoli 1874
© 2016 Vincenzo D’Amico e Gianandrea de Antonellis



 invio in corso...
invio in corso...



